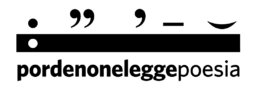La poesia di Claudio Damiani è inconfondibile. Cosa canta, con quale musica, dentro quale ritmo, lo riconosci tra mille. La sua voce si è andata formando dall’inizio degli anni ’80, quando con altri giovani studenti/artisti (Salvia, Salvatori, Colasanti, Scartaghiande, Sica e altri) ha animato la scena letteraria di iniziative, non solo fresche e innovative, ma decisamente lontane dallo sterile sperimentalismo della neoavanguardia. Claudio e i suoi amici pensavano ai classici, come padri putativi, non da imitare piattamente, ma da cui ispirare un cammino prospettico, di rinnovamento insomma, ma ben consapevoli delle radici, del ramo di provenienza.
Eppure, già dalle sue primissime prove, la poesia di Damiani rivelava una identità originalissima. Intanto la scelta lessicale, un linguaggio (che è musica nei versi) “piano”. Damiani, dicono tutti, scrive in maniera semplice, diretta, esplicita. Semplice sì, ma non semplicistica. E del resto, provate voi a raggiungere quel livello di trasparenza e densità allo stesso tempo. L’immediatezza di Damiani non è frutto di un banale spontaneismo, deriva bensì dalla pratica (verrebbe da dire “latina”) di nominare le cose in maniera inequivoca.
E adesso esce questo suo nuovo lavoro “Rinascita” (Fazi Ed, 2025, pagg. 153, euro 18,00). E si rimane un po’ spiazzati dal notare che quasi tutti i testi sono prose. Ma basta leggere il primo testo per sentire immediatamente la stessa musica della sua poesia che già conosciamo. Verrebbe da dire che la prosa stempera la lirica. Ma non è così. Per fare la prova basta leggere ad alta voce i testi. Come suggerisce Dal Bianco, in generale la prova di tenuta di un testo poetico è proprio la lettura ad alta voce. Ebbene, letti ad alta voce questi ultimi testi di Damiani “suonano” esattamente come tutti gli altri. Il linguaggio è lo stesso, il ritmo è lo stesso, affidato appunto a una lingua che è negli anni diventata cifra distintiva di Damiani. Il ritmo infatti è in quel linguaggio piano, mai gridato, a volte tentennante, ma sempre in movimento. È il movimento del pensiero (che rimanda ai poeti latini o cinesi antichi e al lirismo filosofico, non a caso tanto amati dal nostro), che esplora il mondo a partire dal primissimo limite del corpo. Un corpo che si relazione al mondo, alla sua luce, all’aria, al rumore della vita. Così è sempre stata la poesia di Damiani, tanto da tessere veri e propri dialoghi con le cose, tra le cose stesse, riconoscendo loro un’identità originale (quindi non una personificazione). Si noti che la poesia di Damiani, anche quando si fa più schiettamente narrativa, non giudica, non esprime valutazioni, mossa sempre da un sentimento di empatia, meraviglia e amore verso le cose della vita.
Questo ultimo libro si è formato negli anni, per progressive stratificazioni della memoria. Damiani è tornato (anche fisicamente) a più riprese a visitare il villaggio minerario in Puglia, dove, con la sua famiglia, ha vissuto i suoi primi anni d’infanzia (il padre ne era il Direttore). La nota finale al libro (peraltro avvincente come un piccolo prezioso racconto) spiega l’ambientazione e indirettamente giustifica l’amore di Damiani per quella acerba e pure intensa frazione della sua vita.
C’è dunque questo bambino che ogni mattina si sveglia ed esce, sta fuori, letteralmente e fuori si muove, tocca il mondo, ne fa esperienza concreta e primordiale. Tutti gli elementi che entrano in scena (e spesso tornano, si ripetono, si rincorrono) diventano ognuno simbolici di qualcosa di primigenio. C’è la cagnetta Tamara, la relazione tra l’animale e il bambino fatta di tenerezze, giochi e anche dispetto, la loro comunicazione tutta affidata agli sguardi. E poi ci sono anche i dialoghi balbettanti tra i bambini, amici di corse ed esplorazioni avventurose del paesaggio circostante. Ecco, quel balbettìo c’è anche nella memoria di Damiani, che lo gioca sulla carta nel ricordo/non ricordo/si forse, conferendo al racconto un dinamismo confidenziale e anche autentico. Poi ci sono le paure, quelle semplici perciò terribili e profonde dei bambini, le farfalle notturne, i cavalli, gli anfratti inesplorati.
Damiani dopo tanti anni torna ancora a quei luoghi, in parte abbandonati in parte trasformati in agriturismo. E oggi non ha più paura, anzi, può ripercorrere quell’esperienza nel tempo e finalmente riconciliarsi. Dunque, la ri-nascita non attiene a un tornare indietro, o a un ricominciare daccapo. Piuttosto esprime un ri-generarsi, come un rinnovamento della vita, ancora e ancora. Quindi la memoria non si limita a recuperare le immagini del passato, neppure a filtrarle, bensì a rigenerarle in un eterno presente. Quale è appunto quello che fa la poesia, che strappa all’oblìo non per consegnare a una memoria perenne e fossilizzata, ma per rivitalizzare un’esperienza che è senza tempo, oppure sospesa in un tempo che si distende orizzontale, come un maestoso orizzonte pronto ad accoglierci, nudi nella nostra umanità.
Alcuni testi dal libro
Verrebbe voglia, questo villaggio abbandonato, di seppellirlo, come si seppellisce un morto. Sottrarlo allo scempio del tempo, toglierlo via all’abbandono. Interrare le case, le stanze, interrare il canale con tutto l’oro dei suoi fiori caduti. Poi un giorno del futuro, come negli scavi archeologici, riscoprire tutto, riportare tutto alla luce, e capire cose che nessuno aveva capito, neanche quelli che erano vissuti lì, neanche io. Avere la conoscenza del luogo non solo in superficie, come lo conoscevo io, ma anche nell’interno, nelle infinite gallerie che conosceva certo mio padre, ma di cui io non sapevo niente. Solo sapevo che sotto c’era un mondo, sotto la terra c’era un altro mondo, così come anche sapevo poco dei minatori, che venivano coi pullman la mattina e andavano via la sera, e io non li vedevo mai, solo forse ho il ricordo di averli visti di sfuggita bruni e sporchi, opachi, curvi dietro i finestrini annebbiati di una corriera sulla strada asfaltata, mentre vedevo i grossi camion a rimorchio rossi che portavano il minerale, quelli ne vedevo tanti perché passavano in continuazione, cambiando marcia sul rettifilo d’ingresso, il loro rumore forte e rauco invadeva l’aria.
Quando il villaggio era vivo, e ogni giorno si susseguiva vivo a giorno vivo, e intorno alla mia casa, e dentro, potevi sentire le voci, potevi sentire gridi di bambini e richiami di madri. Tra quei bambini, io, tra quelle madri, mia madre. E ho pensato che, dopo che tutto era stato distrutto, e sopra quella terra era passato l’aratro come a cancellare ogni cosa, ho pensato che intorno alla mia casa si riformassero le aiuole e i fiori, gli stessi fiori d’un tempo tornassero a rifiorire. Che, se il tempo ancora c’era, ancora c’era vita, che se cresceva il grano che era stato piantato dopo sui solchi dell’aratro, crescevano anche i fiori che furono piantati in un tempo più antico, e che ancora le farfalle bianche, le cavolaie che inseguivo a lungo con gli occhi da bambino, volassero ancora a coppie come un tempo davanti alla mia casa. E che quelle farfalle e quei fiori evocassero ancora, o trattenessero quasi, quelle voci di bimbi e di madri, come se quelle voci, come erano ancora i fiori e le farfalle nell’aria, fossero ancora nell’aria.
Non dire che la mia casa è triste,
non dire che la mia casa è sola.
Io l’ho lasciata, io non sono a lei più tornato
ed ecco lei è rimasta abbandonata.
Prima il tetto è caduto
poi anche i muri hanno incominciato a incrinarsi,
i mattoncini rossi del parapetto della scala
li hanno portati via,
hanno tolto le pietre ai gradini del patio.
Sono venuti i militari,
ne hanno fatto una piccola fortezza,
hanno messo del filo spinato, hanno sparato dei colpi,
tutto questo ha dovuto sopportare la mia casa.
Ma gli alberi intorno a lei sono cresciuti,
nel silenzio frusciavano le foglioline,
le ombre delle foglie accarezzavano i muri.
Ogni mattina l’alba, ogni sera il tramonto
sul patio la lonicèra profumava,
i fiori ancora fiorivano.
Il tetto lentamente cadeva, ma quante cose d’intorno,
quanta vita segreta che nessuno vedeva,
che nessuno sapeva,
facevano lieta la mia casa, riempivano la sua vita.
Ecco, sono tornato qua
dove tutto è cominciato.
La casa è rotta, non importa,
mi siedo qui sul muretto.
Come mi piace sentire quest’aria sulle mie guance,
l’aria di quand’ero bambino.
e questi cavalli che pascolano
mi piace guardarli.
Guarderei senza mai stancarmi il tempo
che trascorre senza fermarsi.
Del cielo ho una tale sete
e non smetto di berlo.
Perché stare qui non mi dà angoscia?
Vedi, non c’è ansia del tempo.
E’ come se il tempo si fosse fermato
e non ho desideri.
Ho dimenticato, come bagnato
mi fossi, nudo, in un Lete.
Sono tornato all’inizio
completamente rinnovato.
Un’altra casa se ne sarebbe andata
ma la mia casa invece è rimasta lì,
e è incredibile che il paesaggio intorno
anche sia rimasto uguale.
Sì, un po’ è cambiato
ma poco.
I fichi d’India ci sono sempre
i muretti pure
il Gargano non se ne è andato
i formicai ci sono ancora,
la terra è ancora piatta
e il sole nasce all’orizzonte
e tramonta all’orizzonte.
La sera, mentre cammini, la tua ombra si allunga
esattamente come allora
fino a diventare infinita.