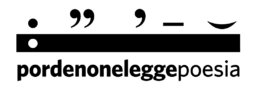Beppe Salvia (Potenza, 10 ottobre 1954 – Roma, 6 aprile 1985) è stato un grande poeta che ha rivoluzionato la poesia italiana negli anni ’80 del ‘900. L’elemento assolutamente nuovo della sua poesia è anzitutto, attraverso la rivalutazione di Pascoli e D’Annunzio (che i poeti del ‘900 dovettero scostare da sé per esistere), la ricollocazione della lingua e della sua tradizione al centro del fare poetico: la lingua è sentita da lui come qualcosa di vivo e pensante, fatta di carne, di senso e sensi, odori sapori colori; è coscienza e memoria di se stessa, e ha casa nella poesia.
È con questa lingua nuova e antica insieme che Beppe può affrontare e dire la “vita nuda”: “Noi proviamo in questa notte a scrivere della vita e della morte” recita l’inizio de Il lume accanto allo scrittoio. “Scrivere della vita e della morte”, eccola qui la “vita nuda”, intera, integrale, con la sua morte accanto. Scrivere perché la vita resti, togliersi dal flusso postmoderno dell’usa e getta, della deperibilità, dall’ideologia del gioco e della vergogna, scrivere per davvero e non per finta, con uno scrittoio vero, e un lume vero, nella notte in cui siamo tutti. Scrivere perché siamo veri, e non fantasmi, e la nostra vita ci chiede di essere scritta, fermata nelle sue infinite immagini che sono la nostra carne il nostro cuore la nostra anima. Uscita dal postmoderno e, anche, dall’ermetismo, laddove non erano riusciti, a detta di Emanuele Trevi, neanche gli sperimentali e neoavanguardisti.
Dopo le varie pubblicazioni, tutte postume (perché anche la prima, Estate di Elisa Sansovino, uscì pochi mesi dopo la sua morte), è stata recentemente pubblicata un’edizione di Cuore (la sua raccolta principale) con attenzione filologica ai manoscritti, a cura di Sabrina Stroppa (Interno Poesia, 2021). Ciò che mancava era una biografia attendibile di Salvia, su storie anche infondate e leggende dovendo poggiarsi gli studi, e sul mito che anche quando era in vita lo circondava, ancor più dopo la morte. A riempire questo vuoto è un libro di Nicola Bultrini, Vita e morte di un poeta, appena uscito per Fazi.
Bultrini non ha conosciuto Salvia personalmente, essendosi per motivi anagrafici affacciato sulla scena letteraria dopo la sua morte, ma ha raccolto, attraverso la frequentazione dei suoi tanti amici e sodali, eredi delle riviste Braci e Prato Pagano (cui Beppe aveva collaborato e che avevano caratterizzato gli anni ‘80 a Roma) il suo messaggio e il suo mito. E questi amici (anche parenti e conoscenti, fino a trentuno in tutto) ha deciso di intervistarli, raccogliendo una gran quantità di materiale sulla vita di Salvia, ma anche sull’ambiente letterario romano di quegli anni. Materiale che lui ha accuratamente vagliato, attraverso confronti e verifiche, fino a arrivare a una ricostruzione il più possibile attendibile con tempi, date, luoghi precisi (questi ultimi ricostruiti e visitati personalmente, da quelli di origine in Lucania e Sicilia alle varie abitazioni romane).
Bultrini crea una sorta di romanzo, fingendosi uno dei poeti amici, raccontando in diretta la vita di Salvia, e dell’ambiente letterario romano di quegli anni, particolarmente vivace e innovativo, dal laboratorio di poesia di Elio Pagliarani allo spazio d’arte e poesia Sant’Agata dei Goti, e poi le riviste Braci e Prato Pagano di cui Salvia fu animatore. C’è anche, tratteggiata velocemente, come in controcampo, la Roma e l’Italia degli anni di piombo, delle stragi e della violenza, e l’autore è bravo a far risaltare il contrasto tra l’orrore e la violenza dell’ideologia, e il silenzio e la pace e la luce della poesia incarnata da Salvia e da questo manipolo di ragazzi che stanno inventando un tempo nuovo, lo stanno già vivendo-.
Bultrini ci fa sentire, raccontando la vita di un poeta innovatore suicidatosi a trent’anni, accanto ai rottami del vecchio, che ancora feriscono, un fervore di cambiamento, di riscoperta di origini e identità, di abbandono dell’ideologia e della violenza a favore della poesia, del silenzio e dell’ascolto, di un rinnovato amore per i nostri classici e per la nostra lingua, preconizzando l’inizio di una nuova epoca.
Claudio Damiani